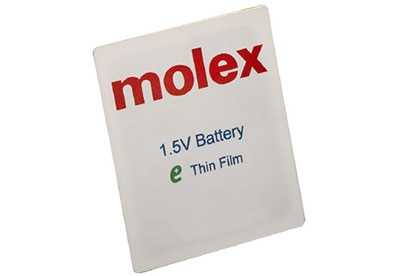Quando avranno il giusto rispetto gli ingegneri elettrotecnici?
La gente in genere ha una buona opinione degli ingegneri elettrotecnici, ma alcuni tipi di ingegneri sembrano essere più apprezzati di altri. Chi progetta sistemi a basso consumo energetico riceve spesso molti complimenti: "È incredibile, con una batteria così minuscola non si è ancora scaricato!". Lo stesso vale per gli ingegneri al computer: "Un programmatore? Il lavoro non gli mancherà mai!"
Sebbene io abbia un debole per gli ingegneri hardware, so che per un progetto solitamente servono competenze tecniche di vario tipo. Quindi darò a Cesare quel che è di Cesare e riconoscerò i meriti di chi si occupa di micropotenza e lavora al computer.
Rimane tuttavia una buona fetta di ingegneri elettrotecnici a cui viene rivolta poca attenzione o cui non viene riconosciuto il giusto valore: sono quelli che lavorano con sistemi ad alta potenza, da diverse centinaia di volt e ampere a decine di kilowatt. Si potrebbe pensare che queste applicazioni non siano riconosciute perché non interessano il grande pubblico, ma in realtà non è così. Le applicazioni ad alta potenza non sono infatti sempre distanti dai consumatori, come avviene ad esempio per quelle industriali o per le linee a catenaria da 25 kV dei treni elettrici.
Pensate ai veicoli elettrici, con cui molti consumatori hanno a che fare più o meno direttamente. Le batterie di questi mezzi di trasporto hanno capacità che vanno dai 25 agli oltre 70 kWh e sono in grado di fornire 300-400 V a circa 1000 A (i motori di trazione possono produrre fino a 300 CV, se non oltre). Tutti questi numeri (capacità di energia, tensione, corrente) ci fanno capire che progettazione, test e manutenzione sono di fondamentale importanza per elementi come il gruppo di alimentazione, la conversione, la gestione e la distribuzione dei veicoli elettrici.
La differenza tra questi ambienti di progettazione non è una semplice questione di cifre o di scale numeriche. L'universo delle potenze elevate richiede modi di pensare e approcci totalmente diversi. Nei sistemi a basso consumo, non è particolarmente difficile mettere in atto una soluzione temporanea come spostare e saldare in più punti un cavo o eseguire un rapido test estemporaneo per provare a realizzare un'idea. Quando invece si lavora a livelli di potenza molto più elevati, ogni azione deve essere programmata, simulata, valutata, considerata e ripensata prima di essere eseguita. L'energia immagazzinata è tanta e deve essere gestita in modo adeguato.
E poi c'è il problema del collaudo. È necessario pianificare con cura un piano di test o organizzare attentamente ogni aspetto che determina cosa fa il sistema e l'impatto di ogni variazione. Saturare rapidamente i conduttori di un voltmetro digitale fino ai punti di interesse è semplicemente impensabile. Persino un requisito di routine come misurare la corrente con uno shunt in linea richiede un'attenta valutazione dei componenti, del circuito di interfaccia, in molti casi dell'isolamento galvanico e persino dei collegamenti fisici da realizzare.
Provate a pensare a questa situazione: volete utilizzare un resistore di shunt per misurare la corrente in un conduttore di corrente elevata. È una tecnica sperimentata, ma vi accingete a misurare centinaia di Ampere in un veicolo elettrico, quindi dovete mantenere il valore del resistore di shunt il più basso possibile per ridurre sia la caduta di tensione indotta dall'IR, che la dissipazione di calore I2R del resistore di rilevamento.
Fortunatamente sono disponibili shunt standard con valori di resistenza estremamente bassi. Ad esempio, la famiglia WSBS8518 di Vishay Dale ha capacità nominali standard di 100, 500 e 1000 µΩ (che corrispondono a solo 0,1, 0,5 e 1,0 mΩ) (Figura 1). Lo shunt, una barretta metallica dall'aspetto incredibilmente normale, è lungo circa 85 mm e largo 18 mm, è in una solida lega di nichel-cromo e vanta un coefficiente termico della resistenza (TCR) di appena ±10 ppm/°C.
 Figura 1: Questo resistore di shunt che lavora a livello di microohm (µΩ) può sembrare piuttosto semplice rispetto ad altri componenti elettronici, ma è progettato e realizzato attentamente in solida lega di nichel-cromo, ha un coefficiente di temperatura estremamente basso e include contatti Kelvin. (Immagine per gentile concessione di Vishay/Dale)
Figura 1: Questo resistore di shunt che lavora a livello di microohm (µΩ) può sembrare piuttosto semplice rispetto ad altri componenti elettronici, ma è progettato e realizzato attentamente in solida lega di nichel-cromo, ha un coefficiente di temperatura estremamente basso e include contatti Kelvin. (Immagine per gentile concessione di Vishay/Dale)
Ma come si collega fisicamente questo resistore alle linee di carico? Dopotutto, anche pochi milliohm di resistenza di contatto dissipano potenza e causano cadute di tensione, quindi anche l'assemblaggio dei collegamenti in derivazione pone dei problemi per la progettazione. Inoltre, anche in questo caso è necessario collegare i conduttori per il rilevamento della tensione; per fortuna questo particolare shunt integra contatti Kelvin che semplificano l'operazione, cosa che altri shunt non fanno.
Non tutti gli ingegneri che lavorano con potenze elevate sono poco considerati; credo che il problema riguardi soprattutto il settore elettrico. In occasione dell'interesse suscitato dal 50° anniversario dell'allunaggio dell'Apollo, è stato straordinario vedere la spinta prodotta al decollo dai cinque motori razzi F-1 che hanno alimentato il primo stadio del Saturn (Figura 2).
 Figura 2: Alcuni tipi di alimentazione sono più visibili, altri meno. Il veicolo di lancio del Saturn V, con i suoi cinque motori F-1, fa decisamente parte della prima categoria. (Immagine per gentile concessione di NASA)
Figura 2: Alcuni tipi di alimentazione sono più visibili, altri meno. Il veicolo di lancio del Saturn V, con i suoi cinque motori F-1, fa decisamente parte della prima categoria. (Immagine per gentile concessione di NASA)
I numeri parlano da soli, anche se probabilmente non sono intuitivi: il primo stadio del Saturn V ha consumato 770.000 litri di cherosene e 1,2 milioni di litri di ossigeno liquido. Ogni pompa di carburante dei motori F-1 era comandata da una turbina della potenza di 55.000 cavalli, che erogava poco meno di 60.000 litri di cherosene al minuto, mentre la pompa di ossigeno erogava 94.000 litri di ossigeno liquido al minuto; ogni turbopompa doveva inoltre sopportare una temperatura in ingresso di 820 °C del carburante che si trasformava in -18 °C per l'ossigeno liquido. Al momento del decollo, i cinque motori hanno generato una spinta totale di 3,3 milioni di Newton.
Provate solo a immaginare quali sistemi di fissaggio sono stati necessari per mantenere fermi i motori F-1 sul banco di prova o per mantenere il Saturn sulla piazzola mentre i motori razzo raggiungevano la massima potenza. Non solo dovevano trattenere una spinta di vari milioni di Newton, ma allo stesso tempo sganciare il razzo piano piano, in modo costante. Come si fa a collaudare una cosa del genere?
Credo che la potenza straordinariamente visibile di un razzo renda il giusto rispetto agli ingegneri che ci hanno lavorato, indipendentemente dalla buona riuscita del lancio. Dato però che l'energia elettrica è meno visibile, gli ingegneri elettronici non ottengono la stessa considerazione. La lunga scia di gas di scarico di un razzo rende tutto incredibilmente reale, mentre gli elettroni di un pacco batteria funzionano silenziosamente e quindi non fanno scalpore.
In futuro forse gli ingegneri elettronici che si occupano di livelli di potenza elevata saranno tenuti in maggior considerazione? Non lo so. Ma sarebbe giusto, perché applicazioni per il mercato di massa come i veicoli elettrici, l'energia solare e reti più intelligenti avranno bisogno di tutta l'esperienza possibile in kilowatt e megawatt.
Riferimenti:
1 – Roger E. Bilstein, "Stages to Saturn: A Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles" file di 168 MB scaricabile gratuitamente qui; download gratuito dei singoli capitoli qui, in inglese)
2 – Charles Murray & Catherine Bly Cox, "Apollo: The Race to the Moon"
3 – Wikipedia, "Rocketdyne F-1"

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum